È il 1° dicembre 2022 e la nota rivista cinematografica del British Film Institute pubblica, come ormai ogni dieci anni da più di settant’anni, la (questa volta controversa) classifica dei 100 migliori film della storia del cinema. Controversa in quanto al primo posto svetta come un’anomalia sistemica il capolavoro di Chantal Akerman Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975). È la prima volta dal 1952 che l’opera di una regista donna viene riconosciuta al punto tale da essere definita come il miglior film di tutti i tempi, ma è anche la prima volta che un lavoro dall’impianto così rigorosamente formalista, così debitore di un certo cinema di matrice strutturale, risuoni un eco che vada anche al di là dello stretto recinto comunicativo cui è destinato il cosiddetto cinema sperimentale. Sembra una beffarda collisione astrale la morte, nel giro di pochi, pochissimi mesi, di tre tra i più intransigenti artisti che abbiano riformulato nelle sue conseguenze più estreme e radicali la settima arte. Le tempistiche assumono un tono ancor più surreale se pensiamo che due fra questi, Jean-luc Godard e Michael Snow (il terzo è Jean-Marie Straub), abbiano esercitato le influenze decisive – come dichiarato più volte dalla regista stessa – per lo sguardo che Chantal Akerman adotterà nel suo rapporto col cinema non solo nella sua opera più famosa bensì nella quasi totalità della sua filmografia, da La chambre (1972) fino a No home movie (2015). “Godard mi ha dato energia e i formalisti mi hanno liberata.” (Chantal Akerman)
E Michael Snow è stato il più formalista tra i registi. Il più impressionista. Colui che più di tutti si è avvicinato a cogliere e restituire la natura macchinica, meccanica ma non per questo meno spitiruale, del cinema. Una natura indagata in forma scritta già nel saggio del 1946 – a dir poco rivoluzionario per l’epoca – L’intelligenza di una macchina, frutto della penna di un altro pioniere del linguaggio audiovisivo quale Jean Epstein. Per Epstein il cinema era al pari di uno strumento scientifico: “la macchina da presa possiede una sorta di cervello meccanico in grado di formulare ragionamenti e offre la possibilità di uno sguardo – più acuto e al contempo disincantato rispetto all’occhio umano – capace di rivelare aspetti del mondo ancora inediti, sconvolgenti, rivoluzionari.”1 Le riflessioni del francese, mai pienamente espresse in forma cinematografica, trovano finalmente cittadinanza nel periodo della maturità artistica di Snow – raggiunto dopo i primi dieci anni di attività filmica tradotti in cinque cortometraggi – che coincide con la realizzazione dei suoi capolavori: lo spartiacque Wavelength (1967), l’orrorifico <—> (Back and Forth) (1969) e il monumentale La Région Centrale (1971). In essi l’idea cementata da Vertov di una perfetta sovrapposizione tra l’occhio umano e l’occhio della macchina da presa viene finalmente sovvertita. Fino ad allora l’evoluzione del linguaggio cinematografico non aveva fatto altro che tentare di colmare la distanza tra uomo e macchina, quest’ultima protesi fatta a immagine e somiglianza del suo creatore. Essendo l’uomo il baricentro dell’uomo stesso, egli non può che proiettare la propria immagine e la propria percezione verso un esterno composto da tutto ciò che non sia l’uomo. Se ne deduce che il cinema può diventare soggetto e destinatario di questo processo, nel quale l’uomo proietta sé stesso nelle cose che lo circondano fino ad una personificazione il più completa possibile. Questo sguardo così fortemente antropocentrico può certamente costituire un formidabile principio di ricerca per permettere all’umanità di scoprirsi e riscoprirsi ma al tempo stesso può rappresentare un ostacolo, una cecità esclusivista per quelle che possono essere le potenzialità dell’arte e, in questo caso specifico, del cinema.
“All’inizio, il cinematografo era solo uno sguardo che registrava (ndr notare bene il termine “registrare”), interessandosi superficialmente a tutti gli spettacoli del mondo; successivamente è stato utilizzato, in certi casi, per l’analisi dei movimenti rapidi e, in altri, per la scoperta dei movimenti lenti. Contemporaneamente, o più tardi, gli è stato insegnato a ingrandire l’infinitamente piccolo, ad avvicinare l’infinitamente lontano. A quest’occhio è stato infine aggiunto, dopo parecchi tentativi, un orecchio e un organo di elocuzione. E, all’improvviso, ci siamo accorti che in questo modo era stato creato una specie di cervello meccanico parziale, che riceve sollecitazioni visive e uditive che esso coordina alla sua maniera nello spazio e nel tempo; e che esprime, elaborate e combinate, in una forma spesso sorprendente, da cui inizia a sprigionarsi una lirosofia (ndr la lirosofia esprime per Epstein la sintesi tra lirismo e filosofia) anch’essa ricca di sorprese. Una lirosofia che, senza dubbio, non è né dovuta completamente al caso, né completamente estranea alle regole dell’intelletto umano da cui è direttamente nata, ma una filosofia di un cervello robot che non è stato intenzionalmente e strettamente regolato per svolgere un lavoro identico a quello dell’organo vivente.”2
Allo stesso modo Snow si contrappone al grande contraltare dello sperimentalismo americano: Stan Brakhage. Se Brakhage filmava, Snow o meglio, il cinema di Snow, registrava. La Région Centrale (1971) è con tutta probabilità il film che in assoluto più si è avvicinato a questa idea di registrazione del reale. Lungo 180 minuti, girato nell’arco di ventiquattro ore, l’ambizione tecnica fatta realtà da Snow consisteva nella creazione di un braccio meccanico programmato appositamente per potersi muovere in qualunque direzione nella sfera dei 360° e controllato attraverso un sistema di pattern sonori a mezzo di nastro magnetico elaborato da Pierre Abbeloos, collaboratore di Snow. “I decided to extend the machine aspect of film so that there might be a more objective feeling, you wouldn’t be thinking of someone’s expressive handling of the thing, but perhaps how and why the whole thing got set in motion.” (Michael Snow) Il movimento è delegato ad altro rispetto al pensiero e all’azione umana, il solo compito del regista consiste nell’innescare il processo. La camera non è più schiava di un diktat umano, l’immagine non è più dominata dal suo regista – Snow non sa come, non sa nemmeno quale, sarà l’immagine filmata dal braccio. L’idea di una rappresentazione coloniale del paesaggio è sfidata, annullata. Il paesaggio non è espressione dell’artista e l’esperienza di tale paesaggio è spogliata di qualsiasi schema percettivo. Ogni inquadratura prodotta è uno spazio generato dalla macchina da presa e dal cinema stesso attraverso i movimenti che esso compie come fosse un pennello imbevuto di un inchiostro che, non appena ne lascia la punta, si dissolve. Gli spazi percorsi dalla macchina da presa non preesistono se non nel solo istante in cui essa li attraversa. L’immagine del paesaggio, del reale, diventa così pura esperienza. Ecco l’antitesi con Brakhage. Per Brakhage la cinepresa è il suo occhio ed espressione della sua visione (tutti i suoi film sono firmati “by Brakhage”, letteralmente “attraverso Brakhage”), per Snow la cinepresa è impressione del reale. Parte centrale della nostra attrazione verso il cinema è, come in qualunque forma d’arte, la riproduzione di noi stessi e l’occhio della macchina da presa è naturale diventi mezzo con il quale far combaciare il nostro sguardo. Ciò spiega come un certo tipo di iper-soggettività nella grammatica cinematografica sia diventata la forma dominante nel linguaggio cinematografico estendendosi soprattutto al movimento della camera che antropomorfizziamo assegnandole intenzione umana.
“Every man’s work, whether it be literature or music or pictures or architecture or anything else, is always a portrait of himself, and the more he tries to conceal himself the more clearly will his character appear in spite of him.”3 Ecco il paradosso che Snow ha forzato, spesso rotto, nell’arco della sua decennale carriera. Un paradosso che vuole la rimozione dell’umano soltanto per permettere allo stesso qualcosa di inedito, altrimenti insondabile, sorprendentemente emotivo e umorale. Formalismi a parte, ciò che più sconvolge del cinema di Snow è la capacità di emozionare, dalla commozione alla paura giungendo fino alla risata. È il caso, oltre che dei già citati, di film come ‘Rameau’s Nephew by Diderot (Thanx to Dennis Young) by Wilma Schoen (1974), definito ironicamente dal regista stesso come una “commedia musicale”, Breakfast (Table-Top Dolly) (1976) sorta di parodia dadaista del suo Wavelenght, quest’ultimo poi ridotto a mo’ di sfottò in WVLNT (Wavelenght For Those Who Don’t Have the Time) (2003). Artista concettuale e metodico ma anche uomo profondamente autoironico e dissacrante, come testimoniato dal divertentissimo So Is This (1982), “film parlante” sconvolgente per la lucidità e la destrezza di Snow nel maneggiare il tempo, anche quello comico, attraverso una serie di inquadrature alle quali corrisponde per ciascuna una sola parola su sfondo nero.
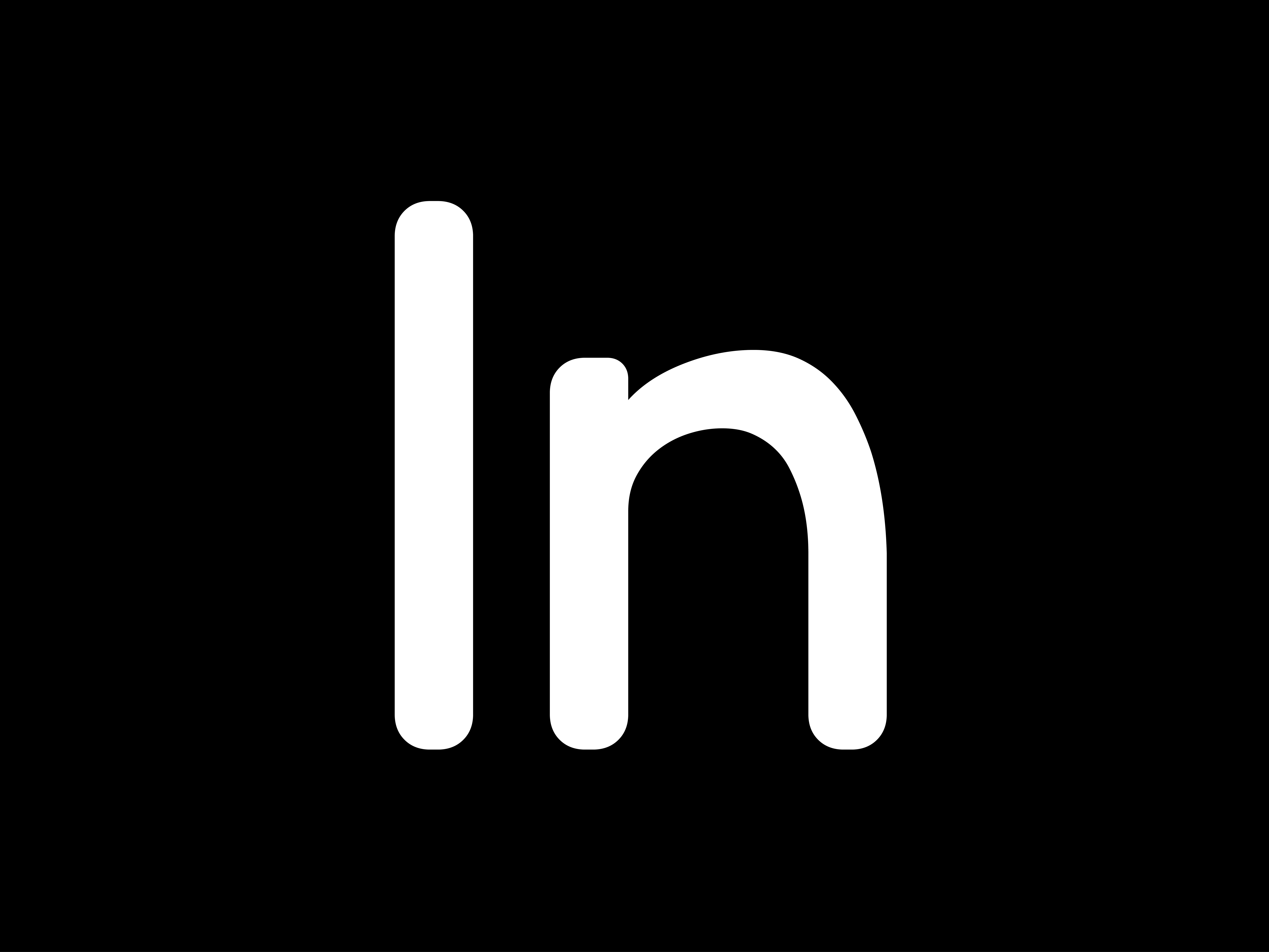













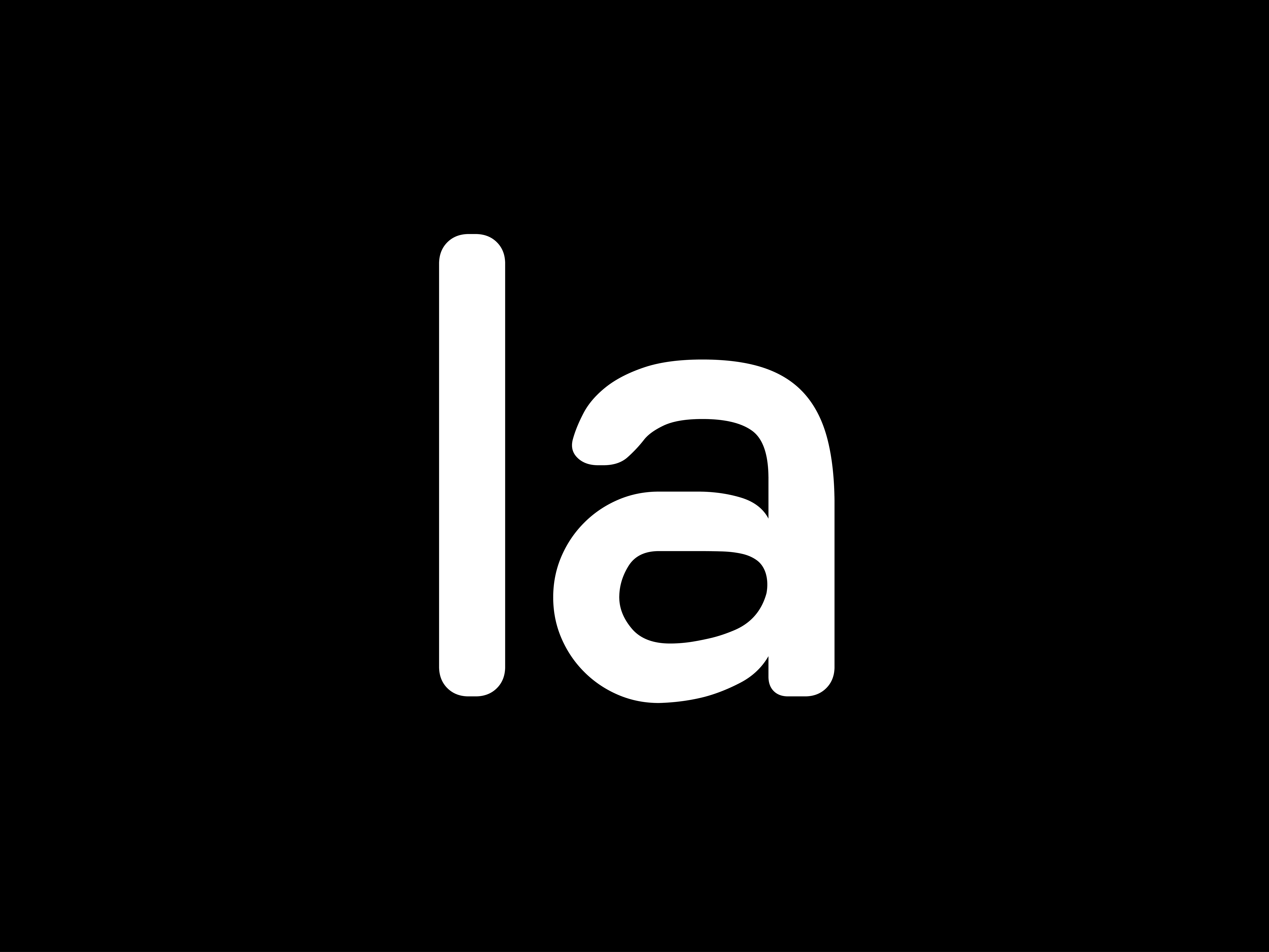





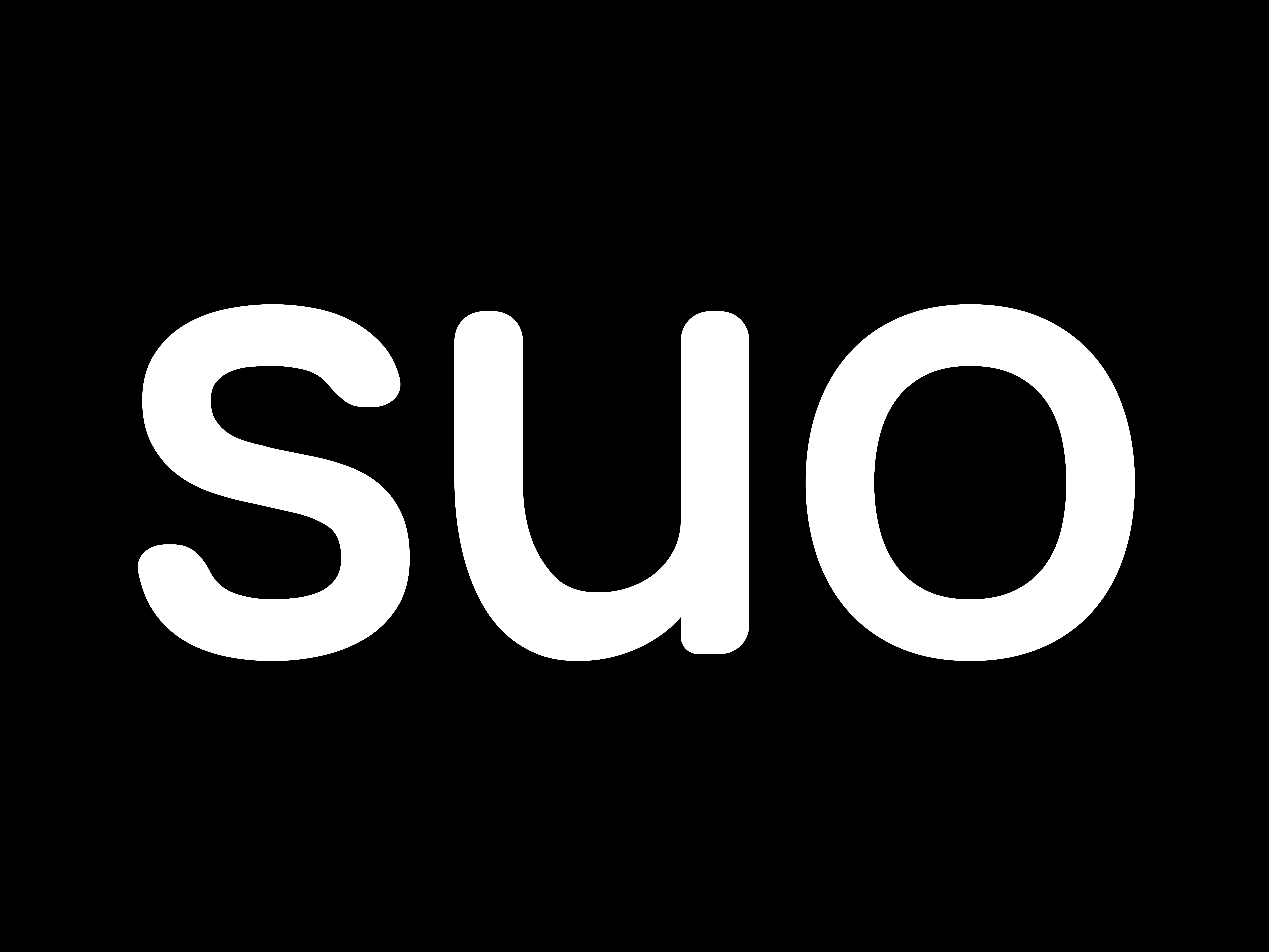







Ma tradurre qualcosa di così specifico e ieratico come il lavoro multiforme e multidisciplinare di un artista totale come Snow (oltre che regista è stato musicista, pittore, scrittore, scultore, fotografo) è pressoché impossibile.
Snow non ha mai smesso di mettersi in discussione. L’ultimo periodo della sua carriera, il periodo “digitale”, ha inizio nel 2000 con The Living Room, cortometraggio poi re-incorporato due anni più tardi nell’ultima, strabordante e delirante magnum opus del regista: *Corpus Callosum (2002). L’incontro-scontro tra Snow e il digitale conduce a un’inevitabile rottura mai così plastica e kitsch della materia con la quale l’artista lavora. L’immagine assume la ruvida concretezza di un marmo virtuale, intangibile se non attraverso i pesanti interventi di post-produzione che deformano, allargano, stritolano all’inverosimile il pro-filmico. Ma se, come abbiamo detto in precedenza, Snow registra la realtà, allora non è un’immagine a piegarsi, bensì la realtà stessa che si ricostituisce a ogni stretch e a ogni loop. Il digitale, come fosse un cesello, non è mai stato così incisivo e tellurico. Come per Epstein, anche per Snow il cinema è stato uno strumento scientifico. Snow è stato un regista altamente tecnologico perché ogni sua opera non poteva prescindere da una profonda messa in discussione di quella stessa tecnologia. Il suo modus operandi, pur mantenendo una coerenza indefessa, si è rinnovato a ogni lavoro perché a rinnovarsi era la tecnologia impiegata. La lezione del digitale ha permesso al canadese una nuova prospettiva rispetto ai discorsi intessuti nei film precedenti. È per questo che nel 2019, a novantuno anni di età, Snow realizza Waivelength, ennesima rivisitazione della pellicola del ’67 e Cityscape, corto girato in formato IMAX che, come già ne La Région Centrale, fa del paesaggio il proprio soggetto con l’enorme differenza che l’orizzonte non è più quello delle montagne canadesi bensì la skyline dei grattacieli di Toronto. La violenza con la quale Snow esegue quello che sarà il suo film è rintracciabile soltanto se torniamo indietro alle inquietanti panoramiche a schiaffo di <—> (Back and Forth). La tarda maestria di Snow nello sconvolgere il paesaggio servendosi di strumenti così basilari come i soli movimenti di camera espone tutta la malleabilità e la fragilità del reale che finisce qui per essere pura astrazione. Un’astrazione formale, concettuale, ma soprattutto emotiva, che non ha bisogno del dramma, che fa a meno di parole e sguardi – se non lo sguardo del cinema stesso – per poter emozionare. A volte, come nel caso di Solar Breath (2002), a Snow erano superflui perfino movimenti di macchina o alterazioni digitali per riportare su schermo esperienze sconvolgenti per semplicità e immediatezza. Una finestra, quella dello schermo, che si affaccia su di un’ulteriore finestra. Una tenda che, ora dolcemente ora bruscamente, viene gonfiata e risucchiata dal vento. Oltre essa un paesaggio, un giardino, che si rivela e si nasconde. L’idillio di un pomeriggio di mezza estate che si lascia vivere nella sua quotidianità. Sensoriale, erotico, fanciullesco. Cinema primordiale, ridotto alla sua essenza. La realtà nella sua forma più pura e intima.