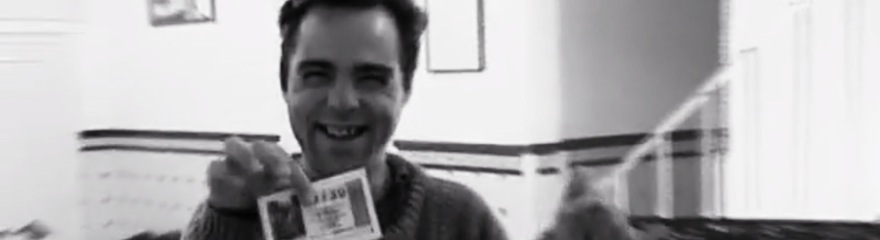Joaquim Jordà, scomparso il 24 giugno di 10 anni fa a Barcellona, può essere definito a pieno titolo come militante impegnato in prima fila in una sfida costante contro il tempo e la fragilità della memoria. Lontano dall’etichetta di “autore”, il cineasta catalano è più ascrivibile alla categoria ideale di corpo attivo, spirito civile, sguardo acuto sulla realtà di un Paese in trasformazione. La sua macchina da presa diviene strumento per ricreare degli incontri perduti, non come dispositivo di riproduzione fredda e meccanica, asciugato da ogni forza perturbatrice, bensì come strumento di sfida per mettersi in ascolto di fronte alla realtà. Incapace di rinunciare all’inevitabile valore pedagogico e didattico del cinema documentario, dà luogo durante tutto il suo percorso ad una vera e propria lotta, animata da una sincera e vivace vocazione all’impegno.
Questo testo non è un’esegesi critica sul suo cinema, ma un’esplorazione, una deriva, un invito allo sguardo e all’ascolto di un cineasta dallo spirito laico, la cui esistenza attraversa quasi mezzo secolo di storia di un Paese, la Spagna, e di una città, Barcellona: il dopoguerra, gli ultimi anni della dittatura, la Transición (intesa come auto-riforma del franchismo) fino all’affermazione definitiva del regime monarchico-costituzionale bipartidista.
L’Escola de Barcelona e l’esilio
L’avvicinamento al cinema durante gli anni ’60 portò Jordà a tessere rapporti importantissimi con le numerose personalità che popolavano il sottobosco della capitale catalana. In quel contesto l’opposizione politica al franchismo coincideva anche con un’opposizione radicale nelle forme creative. In seno a quest’intreccio, che guardava alle nouvelles vagues ma anche all’eredità di Buñuel, nacque l’Escola de Barcelona, formata da Pere Portabella, Gonzalo Suárez, Vicente Aranda, José Maria Nunes ma soprattutto Jacinto Esteva. Fu con quest’ultimo che Jordà firmò il suo primo lungometraggio, Dante no es únicamente severo (1966).
La censura lo portò ad allontanarsi dalla Catalogna per trascorrere alcuni importantissimi anni in Italia. Alcuni dei film realizzati nel nostro Paese, prodotti dalla propaganda del PCI, sono tutt’oggi conservati presso l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico: Lenin vivo (1971), Portogallo paese tranquillo (1969), ma soprattutto L’altra chiesa (1969). Questo piccolo film senza crediti, dalla durata di 15 minuti, doppiato da una voce fredda e monocorde, segue i passi di un’assemblea di sacerdoti spagnoli rivoluzionari, riunita a Roma in opposizione al sinodo dei vescovi celebratosi quegli stessi giorni in Vaticano. È qui che Jordà mette in mostra per la prima volta, già spogliato dai vezzi avanguardistici dell’Escola e dalla cecità propagandistica comunista, la sua scommessa come cineasta: filmare l’incontro, essere carne viva in mezzo agli altri corpi, restituire all’immagine ciò che le contingenze storiche e politiche del suo tempo rendono fugace e invisibile. Come direbbe Comolli, “fenomeni da prima volta […] effetti di nascita”.
Numax, prima e dopo
Con la morte di Franco avvenuta nel 1975 la Spagna attraversò un’epoca di enormi cambiamenti politici, sociali e istituzionali: il passaggio dal vecchio al nuovo regime non fu affatto esente da dolori. Nel frattempo a Barcellona, poco lontano dalla Sagrada Familia, gli operai di una fabbrica di elettrodomestici, la Numax, intraprendevano una lotta contro la chiusura irregolare dello stabilimento da parte dei proprietari. Al termine di una lunga e logorante stagione di autogestione, l’assemblea dei lavoratori decise di impiegare le ultime pesetas della cassa di resistenza per finanziare un film che racconti la loro esperienza.
Jordà ricevette il primo dei suoi due più importanti lavori – cosiddetti – su commissione. Nacque un film, Numax Presenta, che già dal titolo e dalla prima inquadratura (una carrellata circolare che segue la lettura del manifesto politico dei lavoratori in lotta durante l’assemblea) si configura come un anti-encargo (è con questo termine che si definisce in lingua spagnola un lavoro artistico realizzato su commissione), ove l’esperienza del film e l’esperienza dello sciopero combaciano. Il film è sempre in fieri. Lo stabilimento Numax si converte in uno scenario vero e proprio, in cui la ricreazione scenica degli avvenimenti salienti dell’autogestione e i dialoghi assembleari, rigorosamente filmati per la maggior parte all’interno dei locali della fabbrica, costruiscono nel corso del film un fuori campo ideale: un Paese, la Spagna, dove la promessa di cambiamento si tradusse in brevissimo tempo in un tradimento nei confronti della classe operaia. Fu proprio in quei mesi infatti che si firmarono los Pactos de la Moncloa, coi quali il Partito Socialista e quello Comunista avvallarono l’auto-riforma del franchismo insieme alle forze conservatrici, ridefinendo la struttura dello Stato come monarchia costituzionale. La lotta si arresta, ma è proprio quando tutto sembra terminare che Jordà interviene con una sorpresa finale: riunisce i lavoratori per una festa all’interno dei locali della fabbrica, poco prima dell’abbandono. Qui, in mezzo a danze, bicchieri di vino e canne, il cineasta passeggia con la camera e il microfono, come Jean Rouch in Cronique d’été, domandando ai compagni: “Che farete adesso?”. L’intervento del cineasta si tramuta in un dispositivo d’ascolto, nel quale poi è opportuno ritrarsi per lasciare spazio alle altrui voci. Dalla sconfitta emerge un rinnovato spirito, frutto di un processo di crescita collettiva che si manifesta in tenere promesse d’amore, progetti per il futuro, nonché nette dichiarazioni d’intenti: “Non tornerò mai più a lavorare in una fabbrica!”. Tra le pareti di Numax, trasformata ormai in una balera, risuona malinconicamente un tango di Gardel, Adios muchachos. Proprio sulle note di un altro brano di Gardel Jordà farà ritorno sul luogo del delitto con un nuovo film, Veinte años no es nada.
Venticinque anni dopo Numax presenta – film ostracizzato tanto dalla sinistra ufficiale, per l’infedeltà rispetto alla linea segnata dai patti della Moncloa, quanto dai sindacati, che lo giudicarono pessimista – l’eco della festa finale di quelle riprese genera infatti un nuovo incontro. Il cineasta ritrova uno ad uno i personaggi che furono protagonisti di Numax: le lavoratrici e i lavoratori di allora sono diventati tassisti, maestre, artigiani, cuochi, commercianti, hippies… ognuno con la sua storia personale, tutti legati da un passato comune di lotta. Rispetto alle idee dominanti sui movimenti operai, talvolta considerati massificanti e spersonalizzanti, Jordà si concentra sull’esperienza individuale di ciascuno dei personaggi, vissuta a partire da un processo collettivo. Veinte años no es nada, pur attraversando due decadi di “mediocrità e orrore” (secondo le parole dello stesso Jordà) – dalla transizione della Spagna dal Franchismo fino all’integrazione nella UE, nella Nato, nell’Euro – mantiene fisso lo sguardo su ciò che di più importante i protagonisti di Numax hanno saputo trattenere a sé dell’esperienza di lotta vissuta insieme: “L’idea di non poter cadere mai più in certe bassezze, di non poter essere più ingannati”. Necessariamente i due film creano un dittico, col quale si formula una critica feroce al sistema del lavoro salariato. Ad ogni modo, la chiusura degli stabilimenti e la perdita dello spazio-fabbrica generano in Veinte años no es nada una dispersione geografica, metafora dell’atomizzazione sociale seguita alla scomparsa di quella classe operaia. L’esperienza filmica in fieri di Jordà, che attraversa l’intera penisola iberica alla ricerca degli ex lavoratori di Numax, rivela uno sforzo titanico di ricongiungimento, una reazione a quella che è senza dubbio una vittoria del capitalismo: la perdita degli spazi comuni.
Tra i personaggi, due in particolare catturano lo sguardo del cineasta: sono Juan e Pepi. In seguito alla sconfitta della strategia dello scontro collettivo, a causa del tradimento dei partiti progressisti, la giovane coppia scelse di intraprendere la lotta individuale a mano armata. Da attivisti sindacali trasformati in rapinatori di banca, la loro parabola sfocia nell’arresto di Juan in occasione di un colpo spettacolare effettuato nei pressi di Tarragona. Jordà recupera le immagini della diretta televisiva di allora, dove Juan, in un ultimo e disperato tentativo di salvezza, chiede di poter parlare in diretta con l’allora Ministro dell’Interno Barrionuevo (socialista, membro del governo di Felipe González, poi implicato anni più tardi nel caso dei GAL, gruppo para-poliziesco impegnato nella “guerra sporca” contro l’ETA). Alla conclusione del film c’è un’altra festa finale, con i protagonisti che assistono alla proiezione di Numax presenta. Prima della despedida, questa volta definitiva, il figlio sordomuto di uno degli ex lavoratori dello stabilimento scoppia in lacrime: “Non può parlare, solo si può esprimere”. Di fronte alle immagini del film precedente assistiamo alla rivelazione di una scoperta: il figlio conosce forse per la prima volta il passato del padre. La reazione emotiva di fronte ad un vissuto (che è allo stesso tempo per il giovane un non-vissuto) testimonia una trasmissione in corso, forse in prospettiva uno strappo generazionale ricucito, possibile solamente grazie all’ostinazione di uno sguardo e di un gesto che vede nel ricongiungimento, nell’incontro una – l’ultima? – forma di resistenza.

El Cazador e I mari del Sud
Una ricca vedova e il suo avvocato chiedono al detective Pepe Carvalho di indagare sulla scomparsa e l’assassinio del marito, il miliardario Stuart Pedrell. Unica traccia, un verso di Salvatore Quasimodo, lasciato come testamento su un taccuino: Più nessuno mi porterà nei mari del Sud.
È questa la trama del romanzo Los mares del sur, primo grande successo letterario di Manuel Vázquez Montalbán. Il protagonista ricerca le ragioni della scomparsa di un uomo, che inizialmente si pensava fosse andato a cercare il suo paradiso perduto, nel sottobosco della Barcellona della Transición, tra salotti buoni e vecchie bettole, libri antichi, sedi di partito e un rione popolare di nuova costruzione. Jordà, coetaneo di Montalbán, attraversa una Barcellona non dissimile da quella attraversata da Pepe Carvalho nel romanzo, con un destino analogo e un compito ingrato: girare un film sul suo vecchio amico Jacinto Esteva, animatore dell’Escola de Barcelona nonché co-regista del suo primo lungometraggio, commissionato dallo stesso Esteva mediante la figlia Daria. È così che nasce nel 1990 El encargo del cazador (“L’incarico del cacciatore”). Non nuovo a questo genere di imprese, Jordà si domanda tra sé e sé dalla prima inquadratura del film la natura del lavoro su commissione: non è forse l’incarico di Esteva “l’imbecille vanità di un morto”?
Lentamente ci si addentra nel mondo di Jacinto, personaggio polemico e di discutibili costumi, in origine architetto poi cineasta amateur, di ricca famiglia, scialacquatore di patrimoni nonché di personale talento e proprie intuizioni. In questo viaggio nel “cuore di tenebra” della Barcellona tra gli anni ’60 e ’80, Jordà non allontana mai lo sguardo dal suo vero obiettivo: Esteva, la sua parabola umana e creativa, mai scevra dei suoi tratti polemici, evitando sempre di ricorrere a un facile processo su base morale (o di classe). Al contrario, il cineasta non dimentica mai il fuoricampo, ossia l’“habitat” in cui el cazador si mosse – e continua in un certo senso a muoversi: la vanità lussureggiante del morto eccellente non viene da sé, ma si porta dietro tutto il carico di ostentazione e ipocrisia della borghesia catalana di allora, e non solo. Le interviste con i familiari e con gli amici della prima ora, all’inizio del film, non sono mai girate in primo piano. Jordà si posiziona sempre lontano dai volti, mostrando in piano generale gli intervistati all’interno dei loro salotti buoni. Un memorabile piano sequenza svela gli ambienti della gauche divine – la gioventù barcellonese bo-bo degli anni ’60 – nel ricco ritrovo de “El Boccaccio”, tra chiacchiere futili, drink e ricordi di conversazioni sul Vietnam con le mutande all’ingiù.
L’esplorazione prosegue, tra gli amori falliti, ingurgitati e sputati via, bische notturne e innumerevoli battute di caccia all’elefante nella Savana. Il film indugia, sembra essere sul punto di sfuggire di mano al suo regista, ma d’altro canto fa la sua comparsa Daria, la figlia di Jacinto Esteva, che acquisisce sempre più protagonismo man mano che il delirio del padre rende sempre più incomprensibile la sua figura. Jordà la filma, osserva i filmati con lei, le immagini d’archivio di un padre ormai devastato, mantiene l’inquadratura, lei dice “Stop!” e la ripresa si arresta. El encargo, inizialmente previsto come missione affidata a Daria affinché Jacinto rimanesse in vita, diviene sempre più un film su Daria e con Daria, il confronto con i suoi fantasmi, la sua ostinata lotta per mantenere una propria lucidità in mezzo alla follia generata dal padre. Proprio quando siamo con lei, mentre osserviamo incantati i suoi occhi e i suoi gesti nel fumare le sigarette, Jordà brutalmente decide di sottrarre il nostro sguardo ad ogni tipo di condiscendenza erotica alla quale lui stesso comincia a sentirsi sottomesso. La camera tremolante si muove per le stanze vuote della casa di Jacinto, ascoltiamo le registrazioni di un nastro rivolto alla sua Daria: prima canta in francese, poi parla in italiano: “Tuo padre ha un cazzo molto grande… vuoi fare l’amore con me?”. Daria e Jordà si ricongiungono, ancora una volta, nell’affermare il loro sentimento binario di rispetto e spavento nei confronti di Jacinto. Si manifesta forse l’impossibilità di rendere cinematograficamente un omaggio al cazador, e forse con essa si certifica il fallimento dell’utopia di un’intera generazione. È forse impossibile raggiungere i mari del Sud?
Dall’altra parte dello specchio
Dopo le riprese di Un cos al bosc nel 1995 Jordà venne colpito da un infarto cerebrale. Come conseguenza, da allora fino alla sua morte, soffrì di alessia e agnosia. L’esperienza personale ancora una volta si fece linfa vitale per l’esperienza del cineasta. La presa di coscienza sulla debolezza e la fragilità del suo corpo spinsero Jordà a un cambio di posizionamento: il cinema si fece per lui strumento di investigazione sui limiti del linguaggio, ultima àncora di salvezza di fronte al tradimento della memoria.
Il primo film realizzato dopo l’ictus nel 1999 è Monos como Becky. Comincia all’interno di un labirinto: percorrendolo, diverse voci si sovrappongono le une alle altre. Se fino al momento Jordà aveva concepito il ruolo di cineasta come fautore di incontri, un cinema in cui l’intervento consisteva in una “messa in situazione” dalla quale era poi opportuno ritrarsi, ora assume una nuova coscienza sulla presenza del suo corpo nella scena, divenendo soggetto filmico attivo. Un’apparente biopic su Egas Moniz, premio Nobel alla medicina portoghese passato alla storia come ideatore della leucotomia prefrontale, si mescola con le vicende di un centro mentale nei pressi di Barcellona (El Molí di Puigvert). Avvenimenti storici legati alla medicina psichiatrica, al potere (il Portogallo di Moniz era quello dell’Estado Novo di Salazar, vicino al regime di Franco) e ricreazioni teatrali si legano a un avvicinamento quasi microscopico alle persone che abitano il centro mentale. “Visto da vicino nessuno è normale”, diceva la frase attribuita a Franco Basaglia, ma nel caso di Monos como Becky non assistiamo semplicemente a un’approssimazione scientifica, bensì a una compartecipazione vitale oltre che drammatica. Jordà appare nell’inquadratura con la sua troupe, parla con i pazienti della clinica, appare in un auto-intervista raccontando il suo caso di embolia cerebrale, fino perfino a conversare con gli abitanti del Molí sulle medicine da assumere: “Questa pastiglia è uguale a quelle che prendo io. Tu quante ne prendi al giorno? Bè, siamo un po’ nella stessa situazione…”.
Nel suo film postumo, nonché testamento cinematografico Más allá del espejo (2006) Jordà si immerge in prima persona in una maniera ancora più forte, svelando il mondo delle malattie cerebrali che affliggono la percezione della cosiddetta “realtà”. Il rischio della perdita della memoria è la grande problematica che attraversa in qualche modo tutto il cinema di Jordà, persino prima della malattia. Tuttavia nell’ultima fase del suo percorso registico avviene una sorta di conversione, come una sorta di caduta di cavallo di San Paolo, alla cui base poggia un pesante interrogativo: che cosa rimane dell’essere umano quando il corpo sopravvive alla memoria e alle capacità cognitive?
Come suggerito dal filosofo Jorge Larrosa in Monos como Becky, entra in gioco la distinzione storica, risalente all’antica Grecia, del concetto di vita: la zoé, il principio e l’essenza della vita si contrappone al bios, il modo in cui viviamo, che per estensione possiamo considerare il fatto sociale, la condivisione dei fatti dell’esistenza. Il cinema di Joaquim Jordà allo stesso modo è attraversato da questa duplicità: da una parte il flusso caotico e disordinato delle vite, delle esistenze, degli avvenimenti, sotto l’ombra di un determinismo che è tale sono nelle apparenze; dall’altra il desiderio inconscio di ricongiunzione, di fare ritorno in quel luogo fisico, corporale o mentale, che tramite il cinema si fa gesto. Un desiderio che non obbedisce a nessuna fede né alla ragione, ma solamente a un sincero anelito umanista, la libertà di ritrovarsi faccia a faccia, in carne ed ossa, anche solo per un’ultima volta.